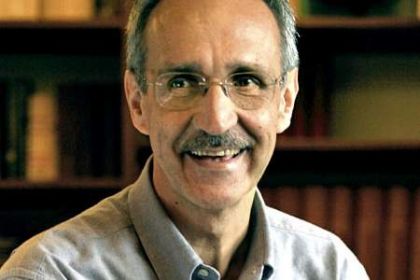 Lettera di Pietro Ichino al Corriere della Sera
Lettera di Pietro Ichino al Corriere della Sera
Caro Direttore,
del progetto di riforma che il governo ha presentato al Paese una cosa è indiscutibile: esso tende ad allineare il nostro sistema di protezione del lavoro a quelli dei nostri maggiori partner europei.
L’allineamento riguarda sia la disciplina dei licenziamenti, sia il riassetto dei cosiddetti ammortizzatori sociali; ed entrambi questi capitoli presentano qualche difetto, dovuto anche alle asperità e ai tempi stretti del confronto svoltosi nelle ultime settimane con le parti sociali, che possono e devono essere corretti.
È importante però distinguere bene il dissenso sui dettagli dal dissenso sull’ispirazione di fondo della riforma.
In materia di licenziamenti, il progetto propone di riservare la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, cioè l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ai casi nei quali è in gioco un diritto assoluto del lavoratore: quello alla pari dignità e alla libertà morale. Dove invece siano in gioco soltanto interessi professionali ed economici delle persone coinvolte, propone una tecnica protettiva diversa, pacificamente praticata in tutti gli altri ordinamenti europei, fatta di indennizzo economico e sostegno del reddito: in questo, oltre che nel superamento del dualismo fra protetti e non protetti, sta essenzialmente il senso della riforma. Se fosse ben chiaro il consenso su questa scelta da parte di tutte le forze politiche che sostengono il governo, non sarebbe affatto difficile trovare nelle prossime settimane l’accordo sulla correzione di alcuni aspetti del progetto che appaiono un po’ troppo tagliati a colpi di accetta. Vediamone alcuni.
Innanzitutto, l’indennità prevista nel caso di licenziamento per motivi economici dovrebbe essere garantita al lavoratore sempre e automaticamente, per evitare l’alea della controversia in tribunale e al tempo stesso per farne un efficace filtro automatico delle scelte imprenditoriali; per altro verso, in coerenza con l’idea di una tutela della stabilità che cresca col crescere dell’anzianità di servizio, si potrebbe rimodulare l’indennità di licenziamento in modo che essa consenta una maggiore facilità di recesso nella prima fase del rapporto e protegga invece di più il lavoratore che è da più tempo in azienda.
Quanto al trattamento riservato al lavoratore disoccupato, occorrerebbe valutare attentamente la possibilità di arricchirne il contenuto in termini di assistenza intensiva secondo le tecniche più progredite, responsabilizzando in proposito le imprese che licenziano e stimolando le Regioni a farsi carico della maggior parte del relativo costo, anche con il contributo del Fondo sociale europeo. Una volta stabilita l’entità complessiva dell’onere a carico dell’impresa che licenzia, sarebbe bene che solo una parte di esso consistesse nell’indennità dovuta immediatamente al lavoratore licenziato, mentre un’altra parte dovrebbe consistere in un trattamento complementare di disoccupazione che incentivi l’impresa stessa ad attivare i servizi migliori di outplacement , capaci di accelerare al massimo il percorso verso la nuova occupazione.
Questi potrebbero essere alcuni dei contributi positivi del Parlamento al miglioramento del progetto governativo. Si profila invece una discussione di tutt’altro genere tra le parti politiche. Con la Lega – del tutto dimentica della propria politica del lavoro negli ultimi dieci anni – che si incaricherà della difesa «senza se e senza ma» del vecchio assetto dell’articolo 18, in contrapposizione frontale con il PdL, suo alleato di ieri, schierato con la stessa determinazione nel senso opposto.
Quanto al Pd, esso dovrà innanzitutto chiarire a se stesso e all’opinione pubblica se condivide la scelta di fondo di armonizzare il nostro ordinamento del lavoro rispetto al resto d’Europa, cercando in particolare di allinearsi agli standard dei Paesi più avanzati. L’incertezza del Pd su questo terreno è tanto più incomprensibile, se si considera che questo progetto del Governo è in gran parte costruito con materiali programmatici prodotti proprio dal dibattito interno di questo stesso partito. È stato soprattutto il Pd, in questi ultimi anni, a denunciare il regime di apartheid fra lavoratori protetti e non protetti nel tessuto produttivo italiano. È frutto di una elaborazione proposta in quattro disegni di legge democratici di questi anni la tecnica normativa adottata nel progetto del Governo per contrastare l’abuso delle collaborazioni autonome in posizioni di lavoro sostanzialmente dipendente. È stata lanciata nell’assemblea programmatica di Genova del 2010 la proposta di far costare il lavoro a tempo indeterminato un po’ meno di quello a termine. Infine, non ultima per importanza, è enunciata nel manifesto di politica del lavoro del Pd del marzo 2008 la parola d’ordine «coniugare il massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza di tutti i lavoratori nel mercato».
La riforma proposta dal governo non realizzerà quella coniugazione nella misura «massima possibile»; così come non supererà del tutto il dualismo fra protetti e non protetti, ma per la prima volta nella storia della Repubblica muoverà un passo molto deciso in entrambe le direzioni. Il Pd è nato anche per promuovere questo cambiamento, questo spostamento di equilibrio complessivo del sistema; sarebbe curioso che ora rinnegasse la propria vocazione originaria.
Pietro Ichino



